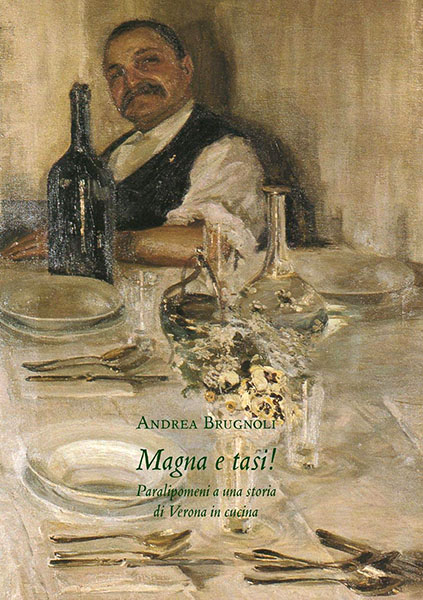La Storia:
L’insolita minestra – Minestra di Fave
(tratto da Andrea Brugnoli, Magna e Tasi! Paralipomeni a una storia di Verona in cucina, Gianni Bussinelli editore, Verona 2014)
Da alcuni decenni, ogni seconda domenica di novembre – era il giorno di San Martino, ma per ragioni di marketing è stata spostata a questa data “mobile” – si tiene a San Giorgio di Valpolicella una manifestazione centrata sulla distribuzione a tutti i capifamiglia del paese, in proporzione al numero di componenti, di una minestra di fave. La manifestazione, sebbene come in tutti questi casi si cerchi di promuoverla nel segno di un’ininterrotta antichissima tradizione, è frutto di una riproposizione organizzata nel corso degli anni Settanta del Novecento, ma ha pure sicuramente una sua base storica e una complessa stratificazione di ragioni di cultura alimentare, sociale e religiosa.
La pratica di una distribuzione rituale di cibo a San Giorgio aveva attirato l’attenzione del vescovo Ermolao Barbaro nella visita pastorale del 1460: risultava come la pieve ricevesse alcuni donativi in frumento, pane, carne e fave, olio e vino alla vigilia di San Martino e il prelato dispose che venisse sí distribuito del pane, ma si evitasse di celebrare pranzi comunitari («non fierent ista convivia»). Disposizione di poco effetto, se nel 1530 il vescovo Gian Matteo Giberti poté ancora avvertire l’odore se non di paganesimo certo di pratica superstiziosa di questo pranzo ancora regolarmente celebrato, che mal si adattava al rigore evangelico con cui intendeva riorganizzare la diocesi, e ne impose pur egli la sospensione. Non abbiamo indicazioni per ritenere che tale ulteriore divieto abbia avuto effetto: forse il pranzo comunitario venne solo rivestito temporaneamente in altre forme, dal momento che tali occasioni erano fonda-mentali nelle società rurali per rinsaldare la coesione interna e ribadire i meccanismi di aiuto reciproco che garantivano alcune forme sia di sicurezza sia di pace, come pure di controllo sociale.
Ettore Scipione Righi nella seconda metà dell’Ottocento poteva attestare ancora la vitalità a San Giorgio della pratica di distribuire la minestra di fave nel giorno di San Martino – ma simile tradizione era attestata anche a Lazise, a San Giacomo di Lavagno e a San Floriano –, issando un immenso paiuolo su un masso all’angolo della via principale e chiamando i capifamiglia che ne ricevevano in ragione del numero dei membri, ma ai primi decenni del XX secolo la pratica venne rarefacendosi fino a scomparire, per essere poi ripresa, appunto, negli anni Settanta dalla neonata Proloco di San Giorgio.
In parallelo con gli interessi etnografici di Righi, gli studi avevano d’altronde posto in luce anche il nesso tra alcuni ritrovamenti di età romana che indicavano l’area di San Giorgio come centro religioso del pagus degli Arusnati – popolazione locale di cultura etrusco-retica a cui venne lasciata autonomia amministrativa e religiosa quando Verona venne romanizzata – e questa tradizione che, ponendo al suo centro le fave, richiamava con singolare rispondenza il valore che nel mondo romano questo alimento aveva nei rituali per i defunti (d’altronde a noi oggi ben noti attraverso i dolci detti “fave dei morti”), come descrive Ovidio nei Fasti.
Infine, ma non da ultimo, bisogna ricordare che nell’economia agricola della Valpolicella le fave hanno avuto storicamente una certa rilevanza: alimento di una tradizione che risulta estraneo al panorama culinario attuale. Ma, in fondo, è proprio per la lontananza con cui questo piatto viene percepito che l’attuale festa suscita una generale e incondizionata adesione.
Zucca e Amarone, presupposta tradizione
(tratto da Andrea Brugnoli, Magna e Tasi! Paralipomeni a una storia di Verona in cucina, Gianni Bussinelli editore, Verona 2014)
Tra i piatti che vengono proposti da alcuni ristoranti come appartenenti alla tradizione veronese si trova da qualche tempo il risotto con la zucca e l’Amarone, declinato secondo diverse piccole varianti, in versione piú economica anche come zucca e Valpolicella. Capita anche che questo risotto sia dato come tradizione di lunghissima data. Ma se andate a chiedere maggiori dettagli su questa presunta antichità – non parliamo di dati documentari, per i quali se ne incasserebbe solo un’espressione interrogativa, propria di chi non abbia capito la domanda – difficilmente ne ricavereste qualcosa. Eppure, una tradizione locale, cosí legata a prodotti caratteristici del territorio, qualche traccia dovrebbe averla lasciata.
Allora analizziamo il componente piú caratteristico, l’Amarone. Con tale denominazione non dovremmo risalire a prima degli anni Cinquanta del secolo scorso, dunque poco piú di mezzo secolo da oggi. Se poi consideriamo che una diffusione commerciale – e dunque una certa notorietà – di questo vino la si può fissare alla seconda metà degli anni Sessanta, tale intervallo si riduce vieppiú. Certo, forme di Amarone, come Recioto “scappato”, cioè la cui fermentazione era stata prolungata fino a portare tutta la frazione zuccherina dell’uva in alcool, capitava che fossero prodotte anche prima: ma era un vino non ben considerato e difficilmente si riusciva a collocarlo, non rispondendo a un gusto che semmai prediligeva ancora il dolce. E, dunque, difficilmente avrebbe potuto rientrare nella cucina tradizionale; in ogni caso non con il nome di Amarone: si sa, anche il potere di denominazione vuole la sua parte. Per inciso, è per questo che appare particolarmente ridicolo l’episodio di un recente film hollywoodiano ambientato a Verona – con il solito pretesto di Giulietta e Romeo –, dove la ricetta di un risotto all’Amarone – comunque cronologicamente seguente e forse derivata dalla nostra –, servito in una “trattoria” del centro storico e dall’improbabile nome, viene detta risalire a piú di trecento anni addietro.
Dunque? In realtà non ci troviamo di fronte nemmeno a un caso di “invenzione della tradizione”, cioè a un elemento attorno al quale si costruisce una qualche identità locale, ma, molto piú semplicemente, a un’invenzione culinaria che proprio unendo sapientemente alcuni prodotti dell’agricoltura veronese ha potuto facilmente essere ben accolta, rielaborata e diffusamente riproposta in una significativa forma di appropriazione comune. Perché di questo piatto possiamo sapere anche la data, se non di invenzione, certo della sua prima proposizione in forma pubblica. Si tratta, infatti, di una ricetta ideata da Gian Paolo Marchi, allora docente presso la facoltà di Magistero di Verona, per un concorso di cucina indetto nel 1973 dal settimanale femminile «Amica»: unico concorrente maschile – cosí vantava –, ne risultò anche il vincitore.
La ragione di tale ricetta nasceva sí da una certa inventiva culinaria, coltivata come hobby, ma anche dallo sforzo di dare una diversa destinazione a due prodotti altrimenti troppo caratterizzati e caratterizzanti. La zucca per il suo gusto dolce, l’Amarone – e stiamo parlando di un vino abbastanza lontano da quello del boom che ha conosciuto a partire dagli anni Novanta – che per la sua corposità, durezza, grado alcolico e ricchezza di tannini risultava difficilmente affrontabile se non abbinato a piatti decisamente robusti.
La relativa abbondanza, in quegli anni, di questi due ingredienti nelle cucine veronesi aveva dunque suggerito di sperimentarne un diverso e originale utilizzo. Oggi, con la rivalutazione che ha avuto questo vino – ma anche con la sua trasformazione in qualcosa d’altro: piú leggero, piú aromatico ed equilibrato –, il piatto ha assunto l’aura di una sicu-ra ricercatezza, che, forse, possiamo superare ricorrendo al trucco di far restringere in pentola del piú accessibile Valpolicella, magari aggiungendovi mezza mandorla amara.
Ricordiamo infatti che comunque, sia esso Amarone o Valpolicella, il vino dev’essere portato a ebollizione, sia per togliere quella punta d’acido che trasmetterebbe, come tutti i rossi, al cibo nel suo impiego culinario, sia per non “ammazzare” la tostatura del riso con un liquido freddo. Quest’ultimo accorgimento, a dire il vero, venne trascurato da Marchi che dovette riconoscerne la maternità a Maria Paola Guarienti (da lui stesso definita «la migliore interprete della ricetta»), dall’orto del cui marito Pierpaolo Brugnoli, peraltro, provenivano le zucche utilizzate per le prime sperimentazioni del piatto vincitore del concorso. Per cui, oltre alla data, conosciamo anche i luoghi precisi della nascita di questa tradizione.
Il silenzio delle fave
(tratto da Andrea Brugnoli, Magna e Tasi! Paralipomeni a una storia di Verona in cucina, Gianni Bussinelli editore, Verona 2014)
Al provincialismo che caratterizza molti ambienti veronesi, attenti a qualsiasi riferimento che dall’esterno si faccia verso questa città, è stranamente sfuggito un curioso rimando contenuto nel celeberrimo thriller di Thomas Harris, The silence of the lambs, in italiano meglio noto come Il silenzio degli innocenti. Hannibal Lecter, il serial killer protagonista della vicenda, in uno dei dialoghi con l’ispettrice Clarice Starling rivela infatti di aver mangiato il fegato di una delle sue vittime con delle fave e un grande Amarone («I ate his liver with some fava beans and a big Amarone»). Il passo è sfuggito ai tanti promotori locali, altrimenti attenti a questi dettagli «che portano il nome di Verona nel mondo», forse perché nella versione cinematografica italiana l’Amarone diventa un piú comune e largamente comprensibile Chianti.
La cosa interessante, comunque, non è tanto la citazione di un vino che nel 1988, quando venne scritto il thriller, non era ancora assurto agli odierni fasti commerciali, né al suo abbinamento con il fegato, quanto al contorno di fave. Se, infatti, il fegato alla veneziana è piatto che appartiene alla tradizione culinaria veronese (quello saporito di maiale, in particolare, cotto nella sua retina di grasso e con abbondante cipolla) e dunque alla portata di un qualsiasi turista attento alle specificità regionali, cosa ben diversa è aver azzeccato la proposta di un contorno di fave, alimento storicamente assai diffuso – quanto però ora dimenticato: di qui la meraviglia nel trovare tale abbinamento – nella collina verone-se della Valpolicella, associato oltretutto al folklore locale che lo lega al dialogo coi morti, secondo una tradizione che ne richiama altre di età romana.
La fava, ora non presente in alcun modo nell’agricoltura della collina valpolicellese sempre piú orientata verso il deserto biologico di una monocultura viticola, era invece qui estremamente diffusa ancora alla fine del XVIII secolo, tanto che era soggetta al prelievo di una specifica decima ceduta dalla chiesa da tempo immemorabile in appalto a imprenditori che ne anticipavano la rendita, al pari degli importanti e piú usuali proventi della vite, del grano e dell’olivo. La fava ritorna poi nell’interessante manifestazione della festa a San Giorgio di Valpolicella, dove – lo abbiamo visto – in occasione della ricorrenza di San Martino viene distribuita a tutti gli abitanti una minestra a base appunto di questo legume.
Se dunque dal punto di vista storico e culturale la proposta di un abbinamento fegato-fave-Amarone è sicuramente centrato, anche dal punto di vista piú strettamente culinario esso appare assai azzeccato, unendo il fondo neutro e dolce del legume – che sostituisce degnamente l’odierno uso di una piú scontata polenta e sul quale sicuramente va un filo di locale olio crudo –, con l’amaro della carne, il tutto governato dalla sapidità di un vino che per il suo corpo può ben reggere l’importanza del piatto. Una variante potrebbe inoltre essere quella di ricavare un ristretto di Recioto, con cui presentare il tutto, e, in conclusione, aspergerlo con alcune gocce di un aceto balsamico ricavato dallo stesso vino, se mai qualcuno – vana speranza – si decidesse di riprendere questa scomparsa tradizione, pure attestata in Valpolicella nel XVII secolo.
Il grasso del dì di festa
(tratto da Andrea Brugnoli, Magna e Tasi! Paralipomeni a una storia di Verona in cucina, Gianni Bussinelli editore, Verona 2014)
Epicentro nazionale dei prodotti dolciari da forno – nonché degli stessi forni – il Veronese non conosce peraltro significative tradizioni locali in questo campo: la sua riconoscibilità è appunto semmai legata a produzioni che da artigianali sono divenute industriali, a partire da quel pandoro di cui ai primi anni del Novecento si notava come «recentemente prese voga incontrando il gusto del pubblico» e che viene ora proposto anche in varianti piú ricercate, quali l’offella(sebbene di questa se ne voglia vantare il primato di un’origine indipendente dal nadalíno da un pan di Natale, senza alcuna sicura base documentaria, trattandosi piuttosto del frutto di una generale diffusione di impasti lievitati dolci importati d’oltralpe).
L’assenza del genere dolce, d’altronde, era tanto significativa – ma caratteristica generale del mondo contadino – che l’inchiesta agraria Iacini, riportando un calcolo approssimativo della quantità annuale di generi alimentari consumata dal rustico medio, ne ignorava completamente l’incidenza. Pure il miele, il dolcificante piú a portata di mano del mondo rurale – e dell’antichità – non sembra aver avuto significativo spazio sulla tavola, e dunque nella gastronomia rurale, anche perché tra XIX e XX secolo con l’avvento delle stearine, del petrolio e poi dell’elettricità per illuminazione venne meno la necessità di produrre cera e dunque il numero di alveari conobbe nel Veronese una forte contrazione.
Si tratta, in fondo, della prosecuzione di una distinzione tra cucina “bassa” e “alta”: solo in quest’ultima il dolce trovava spazio, come ci ri-portano alcuni resoconti di pranzi offerti per grandi occasioni – passaggi di reali o notabili – tra XVI e XVII secolo, dove compaiono confetti, pignocade (dolci a base di pinoli), marzapani, confetture, cotognate, zenzero candito, magari realizzati in forme spettacolarmente complesse, come «manifatture de’ zucharj et de spiciarie», in una caratteristica associazione dolce-piccante.
Con queste basi risulta difficile che si possa rappresentare qualche dolce elaborato da una tradizione locale: di qui, forse, anche la prolungata predilezione, a compensazione, del gusto dolce nel vino, o, per i bambini, dell’uva trasformata con un po’ di farina in budini detti súgoli e in generale della frutta (tra cui i dolcissimi fichi e l’uva passa e compresa una sorta di marmellata ricavata direttamente dalle more del gelso e utilizzata come dolcificante) fino all’estremo stucchevole della zucca al forno. Semmai si conoscono dolci legati a occorrenze particolari: biscotti (fave) di pasta di mandorla per il giorno dei morti, brassadelle cioè ciambelline di pasta dolce prima bollite e poi infornate per Pasqua, nadalín, pane dolce che deve il nome appunto alla festività.
Unica eccezione, che abbia anche una qualche attestazione minimamente risalente, potrebbe essere la torta di paparele (tagliatelle sottili): ma, anche qui, torna l’impiego di una base che propriamente dolce non è. Esisterebbe, di per sé, una tradizione di dolci “poveri” fatti per un occasionale consumo domestico, caratterizzati da un’accentuata semplicità di ingredienti e di preparazione: pissote con l’olio cotte sotto la cenere, fugasse scottate sulla graticola, bole di farina di castagne – questa tipica dei banchetti di piazza delle Erbe, assieme alla crema fritta – mentre di recente introduzione sembra la pastafrolla o la sbrisolona, come di provenienza esterna le spongade e invenzione recentissima, per la zona lacustre, sono i zaleti, biscotti di farina di mais e grano con uva passa.
Questi ultimi, però, potrebbero forse rimandare a una torta ora poco diffusa, e soprattutto poco reclamizzata, forse perché venuta meno nella sua forza e povertà a qualsiasi gusto attuale, ma perfetta sintesi di tutto quanto si è esposto. Si tratta di una pissota (si indica con questo termine un prodotto da forno scarsamente lievitato, schiacciato, appunto come la pisa o pinsa) in cui la polenta di mais (già cotta, cioè avanzata dal giorno prima) è impastata con farina, un po’ di zucchero e dei fichi secchi e legata con un grasso. Una variante prevede che quest’ultimo sia lo strutto che galleggia nella pentola dopo aver cotto il cotechino. Se questa ricetta può risultare poco invitante al nostro gusto che rifugge dai grassi – ma un fabliaux medievale ricorda del villano che dichiara qualora fosse re «non berrei che del grasso»: è appunto il grasso che rende il senso della festa e dell’abbondanza – nondimeno il risultato è strepitoso, dal momento che lo strutto esalta, senza predominare, i gusti degli altri ingredienti.